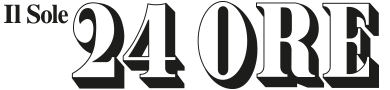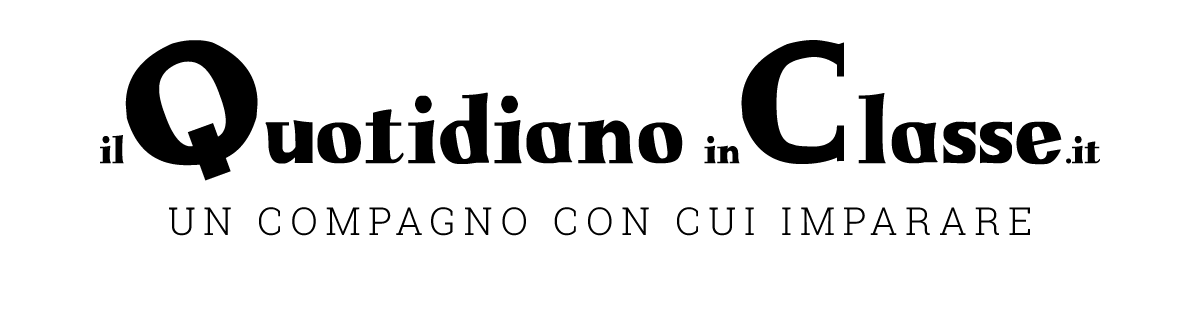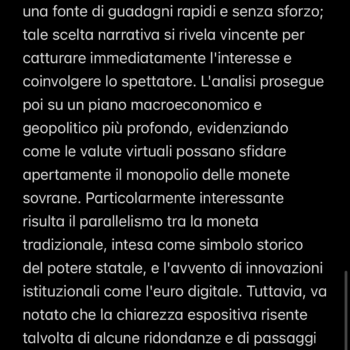L’articolo dell’8 novembre “Israele-Hamas, in rete è già ora dell’assuefazione”, uscito su “Il Sole 24ore”, riporta una ricerca di Arcadiacom.it, secondo la quale l’interesse verso il problema israeliano palestinese starebbe molto diminuendo. Il metro di misura di questo calo è stato individuato nello studio dell’attività sui social network: in altre parole si è dato per inteso che il ricorrere di parole chiave come “Israele”, “Gaza”, “Hamas” e “Palestina”, nelle conversazioni digitali, rappresentasse il livello di attenzione verso l’attuale conflitto. Data questa premessa, l’articolista Marco Lo Conte conclude che sui social network regna la “polarizzazione”, cioè la tendenza a dedicare sempre minore tempo e attenzione ad argomenti anche importanti.
Il problema era già abbastanza evidente con le due grandi emergenze che hanno preceduto il 7 ottobre scorso, ossia la guerra in Ucraina a seguito dell’aggressione russa e la pandemia da COVID19. In entrambi i casi, infatti, si è assistito a una forte “polarizzazione”, seguita da momenti di stanchezza e disinteresse. Il problema di fondo sta forse nel fatto che la tecnologia fa sì che oggi riceviamo un gran numero di informazioni, ma che proprio per la loro quantità facciamo via via più fatica a selezionare e a riordinare. A ben riflettere, i mezzi tradizionali di informazione come giornali, radio e televisioni sono nati per questo scopo: dare l’opportunità all’opinione pubblica di accedere ad un numero crescente di notizie, che vengono selezionate, rielaborate e commentate da professionisti del settore, i giornalisti. La stessa organizzazione delle redazioni giornalistiche rifletteva questa finalità, essendo tradizionalmente divise in “servizi”, come “esteri”, “interni” e “culturale”. Il giornalismo, attività molto criticata e discussa, con tutte le sue imperfezioni aveva però la funzione di mediare tra l’”alluvione” informativa e i lettori. I social network, invece, non presentano un’organizzazione in redazioni, ma consistono in bacheche virtuali, su cui ognuno può esporre la propria opinione. Che si parli di fisica nucleare, di economia o di virologia, ciascuno è legittimato ad intervenire. I social network creano in questo modo un senso di appiattimento, per cui diventa quasi impossibile distinguere un’opinione valida da una meno valida, un’informazione vera da una verosimile o falsa. Questo non significa che ognuno non abbia diritto ad avere un’opinione su qualsiasi argomento, ma che deve esistere una gerarchia tra le opinioni. Alcune saranno più credibili o autorevoli, altre meno. Il peccato originale dei social network consiste nel creare una sorta di rumore di fondo, che impedisce alle opinioni più serie e veritiere di affermarsi.
La misura dell’attenzione ai cosiddetti “trend topics” sui social network finisce per essere un modo per evidenziare l’impatto emotivo che le notizie più gravi hanno sulla collettività, non certo per valutare il peso delle stesse notizie. Scoprire che l’attenzione anche verso le tragedie più terribili nel giro di poco tende a calare non rappresenta né una novità né un giudizio di carattere morale. Molto più interessante sarebbe capire come i social network contribuiscano al formarsi di un’opinione pubblica libera ed indipendente, se continuano a mettere sullo stesso piano qualsiasi tipo di informazione. “Uno vale uno” è uno slogan del “Movimento 5S” che ha generato parecchi fraintendimenti: che uno valga uno, in termini di dignità, è sacrosanto, ma che uno valga uno in termini di competenza è molto diverso. Continuare a misurare i “trend topics” con questi metodi conduce ad una società povera culturalmente, in cui i singoli non riescono più a elaborare un pensiero critico e personale.